TRAMA
Un uomo e suo figlio vagano tra i gelidi paesaggi di quelli che un tempo erano gli Stati Uniti, ora devastati da un’apocalisse.
RECENSIONI

Viaggio nella speranza
C’è una cupezza tangibile nell’opera di John Hillcoat tratta da un romanzo breve di Cormac McCarthy, ma anche molta voglia di speranza e alla fine è questa ad avere la meglio e a indirizzare il racconto. Molto efficace nel tratteggiare l’atmosfera post-apocalittica in cui un padre e un figlio vagano cercando di dare un senso allo smarrimento di chi, pur non rinunciando a vivere, si limita a esistere, il film inciampa in dialoghi didascalici, personaggi un po’ binari, anche nella ricerca di sfumature, e nel peso di una tesi tutto sommato ottimistica. A una prima parte serrata e compatta, secca nell’evitare preamboli collocando da subito i personaggi in medias res, crudele nel sottoporli a continue privazioni, nostalgica nel tingere di colori accesi il come eravamo (gli intensi flashback), un po’ ripetitiva nella successione di eventi con cui ravviva il nulla in cui sono costretti a errare, segue un tentativo di ingrigire i buoni propositi minando la forza interiore e la voglia di farcela dei protagonisti. Ma alla luce del finale incoraggiante, in cui le distinzioni manichee si ricompongono, la costruzione del racconto mostra tutta la sua artificiosità evidenziando le forzature su cui era riuscita abilmente a scivolare nel corso della narrazione. Viggo Mortensen, quanto mai in parte, ribadisce il suo talento e la voglia di sperimentarsi senza cedere alle lusinghe di un facile successo. Così come Charlize Theron, che oltre a interpretare un personaggio non facile (la madre rinunciataria), si conferma produttrice di carattere in cerca di alternative al cinema mainstream.

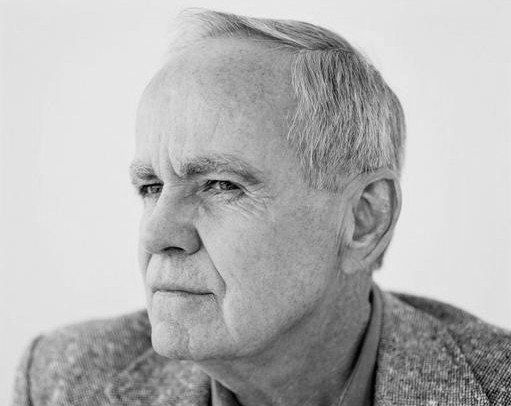
L'apocalisse, ora
Chi conosce i romanzi di Cormac McCarthy sa che essi sono costruiti con uno stile già di per sé cinematografico: le scene sono cariche di dettagli fulminanti che permettono naturalmente la ricostruzione mentale delle ambientazioni; il progredire dell’azione, convulso o rallentato che sia, è sempre in primo piano; i dialoghi non hanno nulla di artificioso e letterario, rifuggono scientemente ogni ricercatezza riuscendo ad essere sempre funzionali, avendo la stringatezza, la basicità, il tono grezzo e l’essenzialità propria del linguaggio parlato. The road, premiato con un Pulitzer già da tempo invocato per uno scrittore che si avvia ad essere un classico americano, è, paradossalmente, il suo lavoro meno rappresentativo: non si vuole dire che non sia un bel romanzo (lo è, molto), ma ponendo la storia di un padre e un figlio senza nome (sono The Man e The Boy) su uno sfondo vagamente sci-fi di un pianeta oramai sconvolto da una catastrofe mai definita, riesce ad allontanarsi, almeno apparentemente, dalle situazioni solitamente predilette dall’autore e già scoperte, peraltro, dal cinema, che continua (e continuerà: è in arrivo l’adattamento di Meridiano di sangue, Tommy Lee Jones ha diretto una produzione televisiva tratta dalla sua piece Sunset Limited ed è nell’agenda di Andrew Dominik la riduzione di Città della pianura) ad attingervi a piene mani, dopo Non è un paese per vecchi (diretto dai Coen) e Cavalli selvaggi (regia di Billy Bob Thorton).
Hillcoat, autore di The proposition, un singolare western australiano scritto da Nick Cave, molto amato (ma leggermente sovrastimato) e divenuto una sorta di cult, alle prese con un testo che sembra già una sceneggiatura pronta, svolge un lavoro corretto, ma privo di inventiva, soggiacendo alle dinamiche descritte e senza mai prendere davvero in mano la situazione. Anche ciò che invece azzarda la sceneggiatura di Joe Penhall non soccorre in alcun modo: i flashback sulla vita preapocalisse spezzano la tensione del gelido presente vissuto dai protagonisti (e sottolineato dalla plumbea fotografia, laddove i ricordi assumono le calde tonalità del mondo felice che non esiste più), la voce fuori campo suona superflua soprattutto alle prese con una scrittura oggettiva come quella di McCarty che nel romanzo non usa la prima persona e d’abitudine rifugge l’introspezione, preferendo il mostrare all’approfondire; Hillcoat e Penhall, pur ricorrendo all’io narrante e pur avendo il supporto dell’immagine, non sempre riescono a restituire la forza dello sguardo di McCarthy, vivo e partecipe al punto da riferirci la temperatura di ogni situazione, ambientale ed emotiva.
E’ proprio questo il punto: The road è un film che sembra mettere insieme ordinatamente, anche inappuntabilmente, tutti gli elementi di un romanzo, rimanendo però fredda illustrazione dei suoi avvenimenti (le varie tappe come microepisodi quasi disgiunti e isolabili) e lasciando da parte qualsiasi dato emotivo, cosa non da poco per un’opera che invece vuol narrare proprio dell’immediatezza, della naturalezza, della commovente protezione che un genitore cerca di riservare al proprio figlio, di un’ancestrale trasmissione del sapere (il padre nutre il figlio anche del ricordo di un mondo che il bimbo non potrà conoscere, ma della cui essenza il suo spirito deve farsi ricettacolo e strumento per tramandarne l’immagine), della necessità di operare un adeguato passaggio del testimone che consenta alla nuova generazione di sopravvivere alla tormentata temperie seguita alla catastrofe.
 Hillcoat, se nel dettaglio risulta soltanto corretto, peraltro, riesce a restituire con una certa potenza visiva il mondo vuoto, giunto al limite, letteralmente senza avvenire in cui si trascina il segmento residuo della razza umana, ormai in estinzione, un mondo incrudelito in cui il rapporto tra questo bambino e suo padre, due corpi in disperato movimento, abbarbicati l’uno all’altro, che sembrano morirci lentamente sotto gli occhi, rappresenta l’ultima vestigia di un senso di umanità oramai andato disperso. Sul fronte attoriale si registra la solita bella prova di Viggo Mortensen, il ragazzino Kodi Smit Mc Phee è un pezzo di legno, la Theron è una meteora con un suo perché. In apparizione straordinaria Robert Duvall e, soprattutto, Guy Pearce, già protagonista di The Proposition, e qui portatore e simbolo di una speranza per un futuro che rimane pura ipotesi.
Hillcoat, se nel dettaglio risulta soltanto corretto, peraltro, riesce a restituire con una certa potenza visiva il mondo vuoto, giunto al limite, letteralmente senza avvenire in cui si trascina il segmento residuo della razza umana, ormai in estinzione, un mondo incrudelito in cui il rapporto tra questo bambino e suo padre, due corpi in disperato movimento, abbarbicati l’uno all’altro, che sembrano morirci lentamente sotto gli occhi, rappresenta l’ultima vestigia di un senso di umanità oramai andato disperso. Sul fronte attoriale si registra la solita bella prova di Viggo Mortensen, il ragazzino Kodi Smit Mc Phee è un pezzo di legno, la Theron è una meteora con un suo perché. In apparizione straordinaria Robert Duvall e, soprattutto, Guy Pearce, già protagonista di The Proposition, e qui portatore e simbolo di una speranza per un futuro che rimane pura ipotesi.


Era ammantato di toni alla Cormac McCarthy anche il precedente, altrettanto crudo e lirico film di Hillcoat, La Proposta, di cui si replicano tracce metafisiche (il padre considera il figlio un Dio, l’ultimo bambino sulla Terra, il futuro migliore dell’umanità, la sana coscienza) mentre è più carente la vena metaforica (la strada della Vita dove, ad un certo punto, il padre deve lasciare camminare il figlio con le proprie gambe): la sceneggiatura è (abbastanza) fedele al romanzo premio Pulitzer nel 2007, e lo scrittore ha gradito l’adattamento, dichiarando “Non assomiglia a niente che avessi già visto”. L’occhio cinematografico di Hillcoat è splendido, il suo post-apocalisse è davvero inedito al cinema, fatto di cenere e morte (con l’ausilio di effetti speciali che hanno posticipato l’uscita del film, girato nel 2008), del colore marrone della decomposizione, di scenari annichiliti vari (ottime location, sfruttando anche la distruzione operata dall’uragano Katrina) in contrasto con i radi flashback del pre-fine del mondo (grande fotografia di Javier Aguirrresarobe) che, nel libro, comparivano solo in forma di sogno. Hillcoat non ha paura di prendersi tutto il tempo per descrivere l’affetto fra l’uomo e il suo cucciolo, di alternare la malinconia sottolineata dalle note per pianoforte (Nick Cave) alla disperazione degli aspiranti suicidi e all’agghiacciante verità di un’umanità che, per sopravvivere in assenza di cibo, arriva a cacciare e mangiare i suoi simili (due scene, in particolare, accapponano la pelle: il magazzino di carne fresca nella casa e madre e figlia in fuga nei boschi; gli autori, però, evitano il passaggio più terribile presente su pagina scritta, quello di un neonato arrostito). Non urla i sottotesti (che, purtroppo, non sono molti), come quello del necessario trapasso per lasciare “la strada” ad una nuova generazione con più fiducia nel prossimo e più altruista (la rivelazione finale sulla “famiglia” che li seguiva).


